Erano passati ormai sei anni da quando mi trasferii in quel buco parcheggiato dietro al campo degli opossum. Ce n’erano a centinaia di quei pezzi di merda, maledetti criminali che nella vita non facevano altro che saccheggiare le case altrui e fumare skunk ed annusare colla. Faceva schifo a tutti, il mio vecchio monolocale, ed anch’io lo odiavo, ma era accogliente e lo avevo arredato come più mi garbava. Oltre al bagno, v’era un’unica stanza che fungeva da cucina, salotto e camera da letto. Era bellissima, con tutti quei poster osé appiccicati alle pareti e quella moquette zebrata che dava un tocco di omosessualità alla mia vita. Ma ciò di cui andavo veramente fiero era l’enorme divano ad L che occupava l’angolo sotto la finestra. La pelle nera, che ricopriva le soffici piume d’oca di cui era fatto, emanava un profumo inebriante, e la sua comodità era tale che mi era difficile alzarmi ogniqualvolta mi ci adagiavo per addormentarmi. Nell’angolo opposto, un piccolo angolo cottura era affiancato da un armadio a due ante sopra il quale si trovava la mia collezione di sveglie antiche, cinquanta orologi tutti funzionanti che ticchettavano in continuazione e suonavano ad ogni ora. Insomma, era un posto piccolo ma accogliente, il rifugio per me più adatto in cui potermi riparare dalla vita frenetica della città.
Vissi da solo per anni, sino a quando, il quindicesimo giorno dell’ottavo mese dell’anno XXXX, venne a bussare alla mia porta uno strano essere dall’aria impaurita e dall’aspetto piuttosto buffo. Era un piccolo ometto verde alto non più di trenta centimetri, con i capelli e la barba dello stesso colore della carnagione, e con addosso un berretto rosso ed una specie di tunica bianca che poteva ricordare un fazzolettino di carta o qualcosa di simile. Mi disse d’essere un folletto di nome Giammaria, scappato dal suo paese natio a causa di una non so quale persecuzione che stava sterminando la sua razza. Mi raccontò, infatti, che tra gli esseri umani v’era un importante sovrano che, avendo scoperto i fantastici poteri del popolo dei boschi, aveva deciso di massacrarli tutti senza alcuna pietà. Lo scopo di tutto era abolire la felicità e l’euforia tra le persone per promuovere una vita grigia, priva di risate e di colori.
Con una faccia un po’ incredula porsi una birra ghiacciata al piccoletto che se la scolò in un paio di sorsi. Quando buttò giù l’ultimo goccio, emanò un potente rutto e decise di mostrarmi ciò di cui era capace: mi balzò sulla spalla e mi scoreggiò dritto in faccia per un paio di volte. Di per lì rimasi schifato e lo colpii violentemente per allontanarlo, ma dopo un paio di secondi mi ritrovai in uno stato mentale che mai avevo sperimentato prima. Rilassatezza, felicità ed una strana sensazione di pace mi attanagliavano la mente e facevano arrossare i miei occhi che sembravano doversi chiudere da un momento all’altro. Ero sballato da impazzire e il mondo mi pareva stranamente divertente ed entusiasmante. Sentii una gran voglia di scoppiare a ridere, ma buttai giù un bel sorso di birra cercando di trattenermi. Tutto mi pareva bello e nuovo, tutto faceva parte di me ed io facevo parte di tutto.
D’improvviso un’idea tanto malvagia quanto geniale attraversò il mio celebro bacato: Giammaria poteva farmi ricco! I suoi inebrianti e maleodoranti peti potevano essere una meravigliosa fonte di pecunia per le mie tasche ormai invase dalle ragnatele. Decisi allora di farlo sbronzare e iniziai a riempirgli il bicchiere con del gin di ottima qualità. Faticai molto, ma inevitabilmente al sesto giro le sue parole iniziarono a perdere di significato e non molto dopo si addormentò.
Devo ammettere che ci rimase un po’ male quando si risvegliò ingabbiato come una passera in una mutanda ferrata, ma lo rassicurai dicendogli che se avesse collaborato lo avrei liberato di lì a poco. Iniziò così il mio business, e la mia gallina dalle uova d’oro rese la mia casa un porto di mare, con gente che entrava ed usciva ad ogni ora del giorno. Per soli dieci dollari vendevo la felicità, per sole dieci monete le persone uscivano con occhi che riuscivano a scorgere cose che prima non vedevano.
Stavo diventando ricco, e man mano che accumulavo pecunia cercavo anche di migliorare le condizioni di vita del mio piccolo prigioniero. Aggiunsi alla sua gabbia un letto, una poltrona e uno di quei televisori portatili, e mi preoccupavo sempre di non fargli mancare dell’ottimo cibo e della deliziosa birra belga. Il bastardo stava diventando grasso e morbido come un lurido maiale tedesco, e viziato e pretenzioso come una stupida femmina ingravidata. Ma in fondo in fondo lo trovavo simpatico e col passar del tempo diventammo pure amici. Iniziammo così a trascorrere le serate insieme, bevendo e parlando di stronzate fino a tarda ora quasi ogni notte. Mi ci affezionai proprio e decisi anche di liberarlo da quella cella che, da quel momento in poi, non sarebbe stata altro che la sua nuova cameretta. Era proprio simpatico ed ingenuo, il piccolo Giamma, simpatico ed ingenuo come un bambino sbronzo o qualcosa del genere.
M’ero innamorato. I suoi occhi sempre arrossati mi accendevano l’animo e mi ricordavano perché vale la pena di vivere, e i suoi meravigliosi peti mi spegnevano la mente e assuefacevano il mio cuore ormai perso. Senza le sue scoregge la mia vita non aveva più senso, senza di lui ero un uomo finito. Quando lo vedevo passeggiare per casa come un pargolo che della vita sa poco o niente, il mio spirito s’infiammava ed il pene mi s’ergeva come non mai. Sentivo il sangue scorrermi sempre più velocemente nelle vene ed i pensieri abbandonarsi a strane e perverse fantasie sessuali. Capitò così che una sera, dopo aver bevuto non ricordo quanti drink, rivelai a Giamma i miei sentimenti e la passione che mi stava logorando il cuore e attivando l’apparato riproduttivo. Quel piccolo figlio di una cagna non comprese però la purezza del mio affetto e mi respinse in malo modo, deridendomi e dandomi del culattone. Ero così infuriato che lo colpii alla nuca tanto forte da fargli perdere i sensi e, accecato dall’ira, privai la sua gabbia di tutti i confort e lo rinchiusi nuovamente.
Nei giorni a seguire abusai ripetutamente di lui e del suo candido fondoschiena verdastro, che dopo un paio di botte iniziò a sanguinare come un cazzo di culo sfondato. Mentre lo privavo della verginità Giamma gridava e piangeva dalla disperazione, ed io godevo sempre più ad ogni suo urlo e lamento. Per la prima volta in vita mia ero felice. Lo rimpinzavo di legumi e quello scoreggiava ed io mi sballavo. Glielo ficcavo su e quello gridava ed io venivo. Tutto era perfetto e le giornate trascorrevano veloci, i soldi non mi mancavano e finalmente avevo trovato quello che credevo essere l’amore.
Una sera, però, rientrai a casa dopo una sbornia in giro con degli amici e trovai il piccoletto che s’era impiccato con un laccio delle mie scarpe da ginnastica. Accanto a lui solo un biglietto in cui v’era scritta, con mano tremula, una singola frase: “Ma vedi d’andartene a fanculo, STRONZO!”. E piansi come non ebbi mai pianto e gridai come non ebbi mai gridato, per la morte di quel tenero omino, che amai come non seppi mai più amare.
Iscriviti a:
Commenti sul post (Atom)




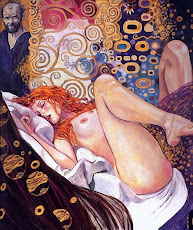























Nessun commento:
Posta un commento